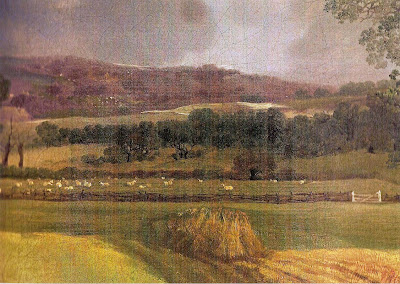Duro il mestiere dello storico dell'arte, ancora di più quello del critico d'arte; ma anche fare il visitatore informato di mostre e musei non è, certamente, cosa da poco. È un terreno minato e, di sicuro, non ci si può improvvisare.
Come si fa a trovare sempre giudizi appropriati ? È davvero una faticaccia. Oggi, mentre leggevo un bel blog che ho scoperto da poco (qui), ho trovato pubblicato il racconto di uno scrittore per me mitico: Achille Campanile.
Non ho resistito alla tentazione di riproporlo qui, per fornire -a chi lo voglia usare- un codice adeguato di comportamento.
Il titolo è "Come visitare lo studio di un pittore". Però, debitamente riveduto e corretto, può valere anche per un museo, una mostra o una galleria d'arte. L'importante è seguire un metodo.
La visita allo studio d'un pittore è una cosa difficile.
Si comincia, di solito, a lodare sventatamente i primi quadri con superlativi; dopo qualche passo, l'incauto, che s'è slanciato a cuor leggero su questa via, deve ripetersi o tentar qualche variante... E poiché la buona educazione, e anche il pittore, vogliono un crescendo ammirativo nei giudizi, a un certo punto il visitatore non sa come andare avanti.
Se il primo quadro è bellissimo, il secondo splendido, il terzo maraviglioso e il quarto magnifico, come sarà il quinto? Mettiamo che sia sorprendente; al sesto vi voglio vedere. Per via del crescendo, esso non potrà che rientrare nell'ordine del soprannaturale. E dal settimo in poi?
Ecco. L'errore in cui cadono quelli che visitano lo studio d'un pittore, è di cominciare dai superlativi. Bisogna, invece, amministrare con previdenza il patrimonio degli aggettivi, magari cominciando con una certa freddezza. Ma se lo studio è molto fornito neppur questo è sufficiente; si comincerebbe con: "passabile, non c'è male, grazioso, bello", e subito si ricadrebbe nel vicolo cieco dei "bellissimo", eccetera.
Dunque? Dunque, signori, cominciare con apprezzamenti tanto più freddi, quanto più numerosi sono i quadri da esaminare, per aver poi il margine necessario al crescendo. Prima di cominciare il giro si domanda:
"Quanti sono i quadri da vedere?".
"Quattordici".
Bene. Per gli ultimi dieci sono a posto. Bisogna trovare gli apprezzamenti per i primi quattro: apprezzamenti freddi, date l'esigenze del crescendo.
Ecco uno
SPECCHIETTO PER QUATTORDICI QUADRI.
1 - Così, così.
2 - Passabile.3 - Niente di straordinario, ma insomma ci possiamo contentare.
4 - Un pochino meglio.
5 - Non c'è male.
6 - Discreto.
7 - Grazioso.
8 - Bello.
9 - Bellissimo.
10 - Splendido.
11 - Maraviglioso.
12 - Magnifico.
13 - Sorprendente.
14 - Soprannaturale.
E se i quadri sono molti di più? Bando agli scrupoli: cominciare con apprezzamenti sfavorevoli. Ci guadagneranno i superlativi finali.
Mentre ci dirigevamo verso lo studio, ho chiesto al signor Gontrano:
"Quanti quadri? ".
"Un centinaio ".
Ho vacillato. Ma non mi son perso d'animo.
Davanti al primo non dico parola; per avere il vastissimo margine necessario al crescendo, e poiché sono un discreto simulatore, ho dato segni di nausea.
"Si sente male? ", fa Gontrano. "Vuole un vomitativo?".
"Non occorre", mormoro. "La vista di questo quadro è più che sufficiente. Mi fa rivoltar lo stomaco".
A mio zio per poco non viene un accidente. Amleto, impassibile, non aveva capito nulla, e Ambrogio dava segni di soddisfazione.
Quanto al signor Gontrano, era allibito. Non gli ho dato il tempo di reagire. Davanti al secondo quadro occorreva attenuare, ma non troppo.
"E' passato", mormoro, "ma anche questo quadro che obbrobrio!".
Gontrano era livido. Io pensavo: "Un po' di pazienza, amico. Fra poco mi abbraccerai". Ma, dopo cinque o sei quadri, a un mio "puah" di disgusto, scoppia :
"Pezzo di mascalzone, alla porta!".
Tanto peggio per lui, che così non m'ha sentito esclamare: "splendido, maraviglioso, incantevole".
E dire che ero già arrivato all'aggettivo "stomachevole".
(Achille Campanile, "In campagna è un'altra cosa")